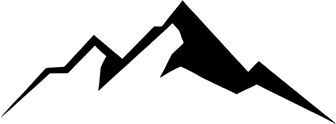Intercultura, sfida educativa per una convivenza pacifica.

CALL NUMERO 1, ANNO 2025.
SCADENZA 15 MAGGIO
Gli spunti di progettazione pedagogica e didattica utili per la nostra contemporaneità sono intrisi di una complessità che reinterpreta il ruolo della formazione e della scuola in una prospettiva necessariamente interculturale.
La risposta alle esigenze delle realtà dei territori solitamente conduce a una riprogettazione del contesto scolastico partendo dalla riscrittura dei curricoli disciplinari, sottostimando la sfida interculturale che dovrebbe essere finalizzata in primis alla convivenza pacifica e fraterna.
Eppure, il documento ministeriale del 23 maggio 2007, a proposito della gestione delle forme di cultura altra, già assumeva il carico di consapevolezza:
“Scegliere la prospettiva interculturale non significa limitarsi a mere strategie d’integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie di carattere speciale. Si tratta piuttosto di assumere la diversità come paradigma dell’identità della scuola e come occasione per aprire l’intero sistema formativo a tutte le differenze”.
La sfida investiva la classe docente italiana, chiamata ad affinare gli strumenti metodologici per inserire la prospettiva interdisciplinare trasversalmente alle discipline scolastiche. Gli insegnanti erano invitati ad affinare il loro gusto per la sperimentazione e per la scoperta di nuovi orizzonti culturali destinati a interconnettersi.
Forme di vita e di relazione diverse contribuivano ad accelerare il cambiamento verso un’attualizzazione dei processi formativi, alimentati da ciò che veniva definito melting pot, crogiuolo, nomignolo attribuito un tempo alla sola città di New York, emblema di un cosmopolitismo esasperato ma sostanzialmente funzionale alla vita dei singoli.
Al di là degli aspetti teoretici, il primo gap concreto che occorre affrontare per un progetto interculturale è ovviamente di tipo linguistico, laddove già il Ministero dell’istruzione, con la Legge 234 del 30 dicembre 2021, prevedeva l’assegnazione di un ‘docente dedicato’ all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero consistente di studenti iscritti per la prima volta al sistema nazionale di istruzione senza essere in possesso di competenze linguistiche di base. Per suddetta Legge, la figura dei docenti assume una valenza tecnica priva di elementi di riflessione.
Per la Legge, parrebbe che le pratiche interculturali già affermatesi siano di tipo “compensativo”, ovvero, rispondono principalmente all’urgenza di compensare gli svantaggi che inevitabilmente patiscono coloro che si ritrovano immersi in nuove realtà; eppure, la scarsa conoscenza della lingua è solo un tassello di una variegata mancanza di cognizioni giuridiche, di convenzioni sociali, di usi e costumi.
Su quali figure si dovrebbe fare riferimento per colmare le divergenze? Quale dovrebbe essere il motore che favorisca il dialogo con le “culture altre” e offrire strumenti per gestire la complessità? La politica? Il ministero? Gli esperti di pedagogia o coloro che dovrebbero formare gli insegnanti?
Il Senato italiano, col Decreto Legge 71 del 31 maggio 2024, ha inserito un provvedimento che contiene alcune misure dedicate all’integrazione scolastica degli alunni stranieri; le indicazioni, ancora una volta, sono centrate sull’apprendimento della lingua italiana e abbassano alla misura del 20% di studenti stranieri il limite che prevede l’implementazione della classe con il ‘docente dedicato’ alla lingua.
Per realizzare il dialogo interculturale nella scuola, l’impreparazione linguistica sembra essere l’unico ostacolo da superare per risolvere i problemi di integrazione-inclusione, in una prospettiva di breve-medio termine; inoltre, a giudicare dalle proposte suggerite dal legislatore, sembrerebbe che gli organi istituzionali destinati alla formazione siano di per sé bastanti per costruire il dialogo tra le culture.
Tale previsione sembra essere destinata a non sortire gli effetti desiderati in chiave interculturale laddove è già possibile verificare, sulla scorta dell’esperienza di paesi che da tempo hanno sperimentato le difficoltà della convivenza, come le differenze vengano conservate malgrado l’acquisizione dello strumento linguistico.
Il dialogo interculturale, per dirsi realizzato, dovrebbe produrre a cascata un miglioramento complessivo del sistema sociale, garantendo per tutti un arricchimento in termini di solidarietà e eticità: s’impone la riflessione su un modello di relazione che favorisca una trasmissione di valori in prospettiva di una socialità condivisa e pacifica.
Il gioco come esigenza fondativa della persona.

CALL NUMERO 2, ANNO 2025.
SCADENZA 30 OTTOBRE
Sono diversi gli interrogativi da porsi sul tema del gioco, argomento per eccellenza della pedagogia.
L’aspetto ludico svolge una funzione insopprimibile nella crescita individuale dal punto di vista emotivo, relazionale, intellettivo e senso motorio. Anche gli aspetti sociali e comunitari si costruiscono e si rafforzano intorno a formule di gioco, le più variegate, in grado di di dare senso e valore all’esistenza umana.
Tutte le manifestazioni espressive, i progetti di apprendimento e le manifestazioni ricreative possono essere reinterpretate metodologicamente in chiave ludica, magari, accelerando i processi di acquisizione e favorendo strategicamente le relazioni.
Acquisito favorevolmente il costrutto di puer ludens, grazie a un’attestata tradizione pedagogica, soprattutto nel quadro scolastico dell’infanzia occorre verificare, anche sperimentalmente, in che modo il gioco favorisca i contesti che l’immaginario collettivo ha sempre considerato, socialmente e moralmente, antagonisti della vita ludens.
Il gioco potrebbe rappresentare una modalità per ridefinire un modo di essere nel mondo che funga da modello educativo, con la valenza strategicamente ulteriore di proporre le regole sociali al fine di una condivisione accettante.
In ultima analisi, il gioco, già validato in ambito pedagogico e sanitario, potrebbe ulteriormente dimostrare la propria valenza come approccio alla comunicazione educativa, in grado di realizzare forme di accettazione delle regole, condivisione degli stili di vita individuali e comunitari, con alla base una proposta diversificata per insegnare la condivisione di vincoli etici.
Tante esigenze sociopolitiche ripensate in modo ludico potrebbero essere ricondotte a costruire relazioni metessiche certamente foriere di un significativo percorso educativo-formativo.
I contributi – da diecimila a quarantamila caratteri – devono essere postati sul “cruscotto”: https://didaskaloi.it/cruscotto/
Deve essere usato il template con le annesse indicazioni editoriali.
Le proposte verranno sottoposte al referaggio attraverso la tecnica del doppio-cieco. La pubblicazione dei saggi verrà comunicata agli autori via e-mail.
Per comunicazioni: info@didaskaloi.it